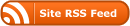L’antica affermazione di Eschilo che “in guerra la prima vittima è la verità” può senz’altro valere in questi tempi di uso massiccio della robotizzazione del lavoro giornalistico e del monopolio informativo ad opera delle agenzie di stampo governativo anche se, in realtà, la verità è sempre nell’occhio del mirino nella società del privilegio e della gerarchia. Comunque questa frase si conferma come utile elemento d’orientamento nel marasma di articoli, interventi, talk show che ci viene quotidianamente proposto. Non aiutano nemmeno i social dove le riflessioni sono sempre più rare nel frastuono dei tifosi dell’uno o dell’altro schieramento.
L’antica affermazione di Eschilo che “in guerra la prima vittima è la verità” può senz’altro valere in questi tempi di uso massiccio della robotizzazione del lavoro giornalistico e del monopolio informativo ad opera delle agenzie di stampo governativo anche se, in realtà, la verità è sempre nell’occhio del mirino nella società del privilegio e della gerarchia. Comunque questa frase si conferma come utile elemento d’orientamento nel marasma di articoli, interventi, talk show che ci viene quotidianamente proposto. Non aiutano nemmeno i social dove le riflessioni sono sempre più rare nel frastuono dei tifosi dell’uno o dell’altro schieramento.
La necessità di tutte le parti in causa, sia di prima sia di seconda linea, è quella di disorientare il nemico, di bombardarlo di dati falsi o fuorvianti; in più, in ogni conflitto è assolutamente necessario compattare la propria parte e disgregare l’opposizione.
La tecnica odierna, lo sappiamo tutti e tutte, consente manipolazioni di ogni sorta, creazioni di filmati ad hoc, riproposizione di materiale “vecchio” magari ripescato da qualche archivio di guerre precedenti. Insomma le fake news si sprecano ma questo non dovrebbe stupirci più di tanto. Come non ci dovrebbe stupire il fatto che la comunicazione, con il passare dei giorni, diventi sempre più a senso unico e sempre più aggressiva nei confronti di chi non si allinea al mantra dominante, in occidente come in oriente.
Pari pari alle indicazioni che troviamo sui mezzi pubblici – non disturbate il manovratore o il conducente – ci viene in buona sostanza intimato di non disturbare coloro che ci stanno portando a danzare sul filo del rasoio, come se a tagliarsi fossero loro e non noi. Non li vedete come si sorridono e si stringono la mano nei summit quelli che dovrebbero trovare una soluzione al tragico conflitto in atto? Il fatto è che gli appartenenti alle classi dirigenti si conoscono e si frequentano tra loro e spingono le classi subalterne – che invece non si frequentano e raramente si conoscono – a massacrarsi vicendevolmente.
I plurimiliardari russi e ucraini, i cosiddetti oligarchi, che stanno dietro questa guerra, si conoscono benissimo, vengono tutti da quell’immensa rapina delle aziende statali operata allo scioglimento dell’Unione sovietica, come pure si conosce una buona parte della gerarchia statale dei rispettivi paesi. Sono i soldati di leva russi, i coscritti ucraini, i proletari e le proletarie di entrambi i paesi a non riconoscersi tra loro come vittime sacrificali di questa guerra, infame come tutte le guerre, perché se lo facessero saprebbero benissimo da che parte rivolgere le armi e in tal caso l’invio di armi e munizioni, oltreché di corpi, sarebbe più che salutare.
Dobbiamo essere chiari: quello in corso è un conflitto tra stati, asimmetrico quanto si vuole, ma sempre tra stati. Sicuramente c’è un aggressore, la Federazione Russa, violento e sanguinario come tutti gli aggressori, che conduce una guerra d’invasione ben sapendo che l’aggredito può solo difendersi senza essere in grado di portare un benché minimo attacco al territorio russo. Sicuramente si tratta di una guerra impari, il cui prezzo lo sta pagando soprattutto la popolazione ucraina qualunque sia l’idioma preferito nel quale si esprime.
Sarebbe però semplicistico addossare la responsabilità della guerra esclusivamente a una sola parte. Il fatto è che da decenni, invece di cogliere i frutti derivanti dalla fine della “guerra fredda” che avrebbero dovuto portare ad una diversa impostazione dei rapporti internazionali, si è continuato a perseguire la politica dell’aumento degli armamenti, del loro perfezionamento, in funzione di una sempre migliore organizzazione della macchina militare.
D’altronde il feticcio della crescita economica permanente da parte di tutti i protagonisti della scena mondiale ha bisogno di nutrirsi con un continuo dispendio di risorse energetiche e un approvvigionamento continuo delle materie prime e delle terre rare indispensabili alla digitalizzazione e alla transizione energetica, fondamenti dello sviluppo industriale e quindi della ricchezza nei prossimi decenni. Sono cose però la cui disponibilità è in poche parti del mondo.
Ogni stato quindi, in quanto espressione concreta – in forma politica – del privilegio, deve operare per garantirsi un posto al sole nella competizione internazionale. Il raggiungimento di questo obiettivo non può conseguirsi che tramite la forza militare: nato e sviluppatosi tramite la potenza delle armi, ad esse deve continuamente rifarsi per potere affermare la proprie volontà. Lo stato, qualunque forma assuma, è sempre l’oppressione organizzata a vantaggio delle classi dirigenti. Questo come valeva ieri vale a maggior ragione anche oggi in tempi di globalizzazione dei mercati, dove le varie consorterie politiche ed economiche si servono del sistema statale in forma flessibile e modulare per il mantenimento e l’accrescimento dei loro privilegi. Ecco allora il rafforzamento di ogni stato in chiave repressiva e di controllo per stroncare ogni possibile ribellione interna, ecco l’alleanza di stati per garantirsi lo “spazio vitale” nei confronti di altri stati.
Non cogliere questo confronto in atto tra i principali protagonisti di un mondo ormai multipolare ci fa ripiegare in una visione semplicistica di quanto sta accadendo. Il martellamento continuo che la gran parte dei media sta facendo sul conflitto in corso vuole costringerci nel vicolo cieco dello schierarsi per poi mobilitarci sul fronte di guerra, anche se noi siamo già schierati a fianco della popolazione sofferente, per la cessazione immediata dei combattimenti, per il ritorno degli eserciti nelle rispettive caserme. Il martellamento però continua: prendiamo, per esempio, l’utilizzo che è stato fatto in questi giorni di una circolare dello Stato maggiore della Difesa, presa a pretesto per titolare i giornali con la notizia che l’Italia si sta mobilitando, accelerando di fatto la militarizzazione in corso e prefigurando una diretta scesa in campo dell’esercito italiano.
In realtà la circolare ha un altro scopo di più lungo profilo, cioè quello di battere cassa per avere più quattrini, più risorse per alimentare l’intera struttura che campa sulla tassazione dei cittadini e sui tagli ai servizi sociali. Quale momento più opportuno per esigere più fondi dallo stato? Ammiragli e generali hanno decodificato il messaggio dicendo che tutte le armi (eccetto probabilmente i carabinieri, da sempre fiore all’occhiello dell’ordine statale) sono in sofferenza di militi (ce ne vogliono di più), di preparazione (cosa ci stanno a fare a “presidiare” le vie cittadine invece di addestrarsi?), di mezzi (la solita carenza di manutenzione). Prontamente il parlamento ha risposto al grido di dolore con le stellette impegnando il governo a incrementare le spese per la difesa e portarle al 2% del prodotto interno lordo. In soldoni vuol dire dai 68 milioni di spesa al giorno ai 104. Chi ne pagherà le conseguenze è presto detto: sanità, scuola, cultura…
I grandi media, più militaristi dei militari, vogliono la prima linea e guai a chi la pensa diversamente. Andiamo a leggere, a questo proposito, quanto in questi giorni di guerra hanno scritto e proclamato in tanti: illustri storici, brillanti giornalisti, filosofi, e tanti leoni da tastiera in difesa dei valori “morali”, storici e culturali dell’Europa nei confronti della barbarie di Putin e dei suoi accoliti. Fiumi di retorica per occultare un fatto incontestabile: l’ipocrisia delle tanto sbandierate democrazie dell’occidente.
In cinque anni in Yemen sono morte 337mila persone, tra le quali 10mila bambini. Ne avete mai visto uno in televisione? Ebbene la mattanza è ad opera di uno stato come l’Arabia Saudita, le cui credenziali democratiche – nonostante gli elogi renziani – sono come minimo altamente discutibili e alle cui spalle ci sono altri difensori della moralità come gli USA, la Francia, la Gran Bretagna.
Sei milioni di palestinesi sono stati espulsi dai loro territori dalle politiche dello stato di Israele, definite da apartheid da un organismo come Amnesty International – di solito omaggiato quando guarda fuori dai cortili di casa nostra. Assassinii mirati, leggi razziste, distruzione di case, annessione di territori, tutto questo non ha meritato una sia pur minima sanzione dai garanti dei valori europei, tutti concentrati a dare valore alla molotov ucraina e a definire terroristica quella palestinese. Ci ricordiamo poi dell’Iraq? Della Siria? Dell’Afghanistan? Della Libia? Degli omicidi di civili definiti “danni collaterali”? Del diverso trattamento riservato ai profughi di guerra? Quanti si esprimono sui respingimenti alla frontiera polacca di chi arriva da guerre “altre”, generalmente “sporche”, le cui motivazioni sono solo apparentemente locali ma, dietro le quali, c’è sempre un interesse delle multinazionali e, dietro di loro, gli stati per l’accaparramento delle terre e delle materie prime: vuoti a perdere nel gelo dei boschi bielorussi utili solo, a suo tempo, a denunciare il cinismo del dittatore Lukashenko.
Meglio muoversi sull’onda delle emozioni umane sollecitate dagli schermi televisivi e redarguire quanti oggi non si vogliono mettere l’elmetto. Se hai solo dei dubbi sull’opportunità di inviare armi all’esercito ucraino diventi un sostenitore di Putin; se – come Donatella Di Cesare – vuoi comprendere tutte le motivazioni che stanno alla base della guerra ti meriti il disprezzo e il sarcasmo degli interlocutori, se – come Barbara Spinelli – ti permetti di riprendere quanto già affermato da analisti statunitensi sull’inopportunità dell’allargamento a Est della NATO diventi, come ha detto Riotta, una “putinversteher”, una sostenitrice di Putin.
C’è anche chi ricorda (Adriano Sofri, Flores d’Arcais) l’appello del settembre 1973 per una raccolta fondi destinata a fornire armi al MIR cileno dopo il colpo di stato di Pinochet, un’iniziativa che si rifaceva al 1936 spagnolo, indirizzata a galvanizzare una militanza convinta che a breve sarebbe giunta l’ora di imbracciare il fucile in un contesto di grande conflittualità sociale. Un’iniziativa con nessuna possibilità pratica di riuscita stante la forza e la violenza dell’esercito cileno e la mancanza di una tensione insurrezionale nel proletariato cileno paragonabile a quella spagnola. Inoltre la realtà sudamericana d’allora mai avrebbe consentito il passaggio di armi verso qualsiasi forma di resistenza.
Ci sono poi quelli (Luigi Manconi) che paragonano l’impegno dell’esercito ucraino alla resistenza contro il nazifascismo, mettendo sullo stesso piano un esercito di professionisti, di una gran parte di coscritti (dai 18 ai 60 anni) e di una parte di volontari, alle bande partigiane che in Italia si erano costituite dopo l’8 settembre 1943 e il disfacimento dell’esercito italiano. L’invio di armi all’Ucraina sarebbe quindi paragonabile ai lanci degli Alleati ai partigiani dimenticando alcuni fatti non certo secondari: le armi i primi partigiani se le erano procurate inizialmente (nel cuneese) dallo scioglimento della quarta armata proveniente dalla Francia, poi attaccando caserme, singoli militi e così via. Altre bande, come quelle di orientamento social-comunista, le armi dagli Alleati le avevano con il contagocce e comunque in funzione degli obiettivi bellici di inglesi e americani. Mi pare completamente fuori luogo come si possa fare un parallelo tra una realtà fatta di militari sbandati, di antifascisti storici, di reduci dalla Russia, di giovani renitenti alla leva repubblichina, di donne combattenti che hanno voluto e scelto di combattere per un mondo diverso e libero dal fascismo – non certo per una monarchia corresponsabile del disastro e per uno stato in disfacimento – con un esercito regolare, ampiamente foraggiato di armi di tutti i tipi da un’alleanza potente come la NATO.
Spiace dover leggere queste considerazioni e questi appelli da persone che hanno contribuito in maniera importante al miglioramento delle condizioni di vita di questo paese; nulla però come la guerra consente di capire a fondo la natura e il comportamento umano. Mentre si discetta di resistenza e si insultano i pacifisti aumenta il clima bellico nella logica della guerra totale. In Russia Putin minaccia e mette in galera, con accuse di tradimento, chi osa dissentire dal suo volere, arrivando a proclamare una specie di guerra santa in difesa dei valori sacri, patriarcali e omofobi, del risorto Impero di tutte le Russie; da noi si dà la caccia al demonio russo, sia che abbia il volto di uno stimato direttore d’orchestra sia quello di un brillante fotografo, Alexander Gronsky, cancellato da un festival di fotografia a Reggio Emilia anche se non poteva parteciparvi visto che è in galera in Russia in qualità di oppositore di Putin; per non parlare della delirante esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle paralimpiadi di Pechino o della censura del corso dedicato a Dostoevskij alla Bicocca di Milano.
La guerra nell’epoca contemporanea, dai conflitti mondiali in poi, non è più guerra di eserciti ma deve necessariamente essere totale, deve coinvolgere le popolazioni in prima linea. Più è estranea al sentire comune più deve trasformarsi in una lotta al male assoluto, al nemico trasformato in “mostro”. Se si capissero invece le reali motivazioni che stanno dietro ogni guerra, cadrebbe ogni maschera e il re apparirebbe nudo.
Dovrebbero far riflettere le recenti dichiarazioni di Wess Mitchell, già assistente Segretario di Stato USA per gli Affari europei ed euroasiatici dal 2017 al 2019: “La guerra dimostra che l’ordine mondiale è entrato in una fase caotica. Le relazioni tra potenze stanno mutando a causa dell’ascesa cinese. (…) La Cina (…) necessita ancora di tre o quattro anni per raggiungere la sofisticatezza militare necessaria a prevalere in un conflitto. Washington dovrebbe sfruttare questa finestra di tempo per infliggere a Mosca dei costi altissimi (…). L’Ucraina è il cuore di questa strategia. Gli Stati Uniti devono utilizzarla per sfibrare, prosciugare e impoverire la Russia, organizzando approvvigionamenti militari continuativi alle forze locali (…). Dovremmo avviare un programma di armamento a lungo termine per gli ucraini, così come facemmo negli anni ottanta con i mujahidin contro l’URSS. (…) L’Ucraina è un’opportunità strategica per l’Occidente (…).” [Limes, 2/2022]
La guerra come opportunità, i morti come opportunità, i bambini e le bambine come opportunità, l’intera popolazione in prima linea come opportunità.
Nel Marzo 1915 un gruppo di 37 esponenti del movimento anarchico internazionale stilarono a Londra un Manifesto Internazionale Anarchico contro la Guerra, in esso vi è scritto: «… per gli anarchici non vi è mai stato, né vi è oggi alcun dubbio (e gli orribili avvenimenti attuali rafforzano tale convinzione) che la guerra è in permanente gestazione nell’odierno sistema sociale. Il conflitto armato, ristretto o allargato, coloniale o europeo, è la conseguenza naturale, l’inevitabile e fatale risultato di un regime che si basa sulla diseguaglianza economica dei cittadini e sullo sfruttamento dei lavoratori; d’un regime che riposa sul selvaggio antagonismo degli interessi, e pone il mondo del Lavoro sotto la stretta e dolorosa dipendenza di una minoranza di parassiti che tengono nelle loro mani il potere politico ed economico. (…) Il compito degli anarchici, nella presente tragedia, qualunque possa essere il luogo e la situazione in cui si trovino, è di continuare a proclamare che c’è una sola guerra di liberazione: quella che in ogni paese è sostenuta dagli oppressi contro gli oppressori, dagli sfruttati contro gli sfruttatori. Il nostro compito è di spingere gli schiavi a ribellarsi contro i loro padroni. L’azione e la propaganda anarchica devono assiduamente e con perseveranza mirare a indebolire e disgregare i vari stati, a coltivare lo spirito di rivolta ed a sollevare il malcontento nei popoli e negli eserciti».
Non mi pare che ci sia motivo per mutare questo impegno.
Massimo Varengo
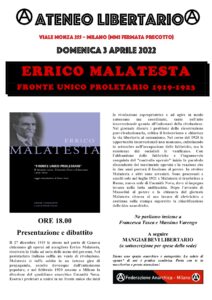

 L’antica affermazione di Eschilo che “in guerra la prima vittima è la verità” può senz’altro valere in questi tempi di uso massiccio della robotizzazione del lavoro giornalistico e del monopolio informativo ad opera delle agenzie di stampo governativo anche se, in realtà, la verità è sempre nell’occhio del mirino nella società del privilegio e della gerarchia. Comunque questa frase si conferma come utile elemento d’orientamento nel marasma di articoli, interventi, talk show che ci viene quotidianamente proposto. Non aiutano nemmeno i social dove le riflessioni sono sempre più rare nel frastuono dei tifosi dell’uno o dell’altro schieramento.
L’antica affermazione di Eschilo che “in guerra la prima vittima è la verità” può senz’altro valere in questi tempi di uso massiccio della robotizzazione del lavoro giornalistico e del monopolio informativo ad opera delle agenzie di stampo governativo anche se, in realtà, la verità è sempre nell’occhio del mirino nella società del privilegio e della gerarchia. Comunque questa frase si conferma come utile elemento d’orientamento nel marasma di articoli, interventi, talk show che ci viene quotidianamente proposto. Non aiutano nemmeno i social dove le riflessioni sono sempre più rare nel frastuono dei tifosi dell’uno o dell’altro schieramento.